La Griglia di MANHATTAN

La griglia governava la pianificazione urbana della civiltà della valle dell’Indo, nell’attuale Pakistan, già nel 3300 a.C. Era alla base dell’organizzazione delle città mesopotamiche del XVII secolo a.C. e di quelle cinesi degli stessi anni; fu il modello scelto dagli antichi Greci per organizzare le loro città a partire dal V secolo a.C. e, nello stesso periodo, da popolazioni precolombiane in Sud America; guidò prima l’organizzazione degli insediamenti etruschi, poi la centuriazione e la pianificazione urbanistica dei territori Romani. La griglia è un’idea antica. Eppure, la griglia di Manhattan fu qualcosa di radicalmente nuovo, di sperimentale e mai più replicato.
Le origini di Manhattan. Il 17 aprile 1524 l’italiano Giovanni da Verrazzano, durante l’esplorazione della costa del Nuovo Mondo finanziata dalla Corona Francese, fu il primo europeo ad entrare nell’Upper Bay e il primo ad incontrare i Lenape, la popolazione di indigeni americani che viveva nel territorio dell’odierna Manhattan. Il nome dell’isola deriva proprio da quello che i Lenape avevano dato alla loro terra: Madanos o Manhattas, isola collinosa.
Solo nel 1609, però, l’area dell’attuale Manhattan fu accuratamente esplorata dagli europei, dopo l’arrivo dell’inglese Henry Hudson, giunto fin lì alla ricerca di una nuova rotta per le Indie per conto della Compagnia olandese delle Indie Occidentali. Percorrendo il fiume che oggi porta il suo nome, Hudson esplorò tutto il territorio circostante Manhattan, fino al punto in cui oggi si trova Albany, la capitale dello stato di New York.
Nel 1624, trenta famiglie olandesi sbarcarono a Manhattan con il compito di fondare una colonia, dando vita al primo vero insediamento urbano, nella punta sud dell’isola. Avevano precise direttive da seguire: il centro della nuova città doveva essere un fortino a cinque punte, attorno al quale le abitazioni sarebbero state organizzate in lotti rettangolari, separati da fossati. Tuttavia, la conformazione del terreno rese impossibile rispettare il piano. Il fortino fu costruito con una forma più semplice, a quattro punte, e le abitazioni finirono per distribuirsi in modo disordinato, adattandosi alla morfologia irregolare del sito.
Nel 1626, l’allora governatore del villaggio Peter Minuit acquistò l’isola dai Lenape in cambio di oggetti dal valore irrisorio di circa 60 fiorini (oggi corrispondenti a circa 1000 dollari), con l’obiettivo di tutelarsi da eventuali rivendicazioni di altri coloni.
“Ieri è arrivata qui la nave The Arms of Amsterdam; salpò dalla Nuova Olanda, dal fiume Mauritius, il 23 settembre. La relazione è che il nostro La gente sta bene e vive in pace. Inoltre, le loro mogli hanno avuto bambini lì. Hanno comprato l'isola di Manhattes dai nativi per 60 fiorini di commercio. Ha un'estensione di 11000 morgens.”
Estratto dalla lettera del mercante olandese Peter Schaghen ai direttori della Compagnia Olandese delle Indie Orientali, di cui potete vedere la foto dell’originale qui

Illustrazione datata 1892 di Peter Minuit nell'atto di acquistare l'isola di Manhattan.
Fonte: Wikimedia Commons
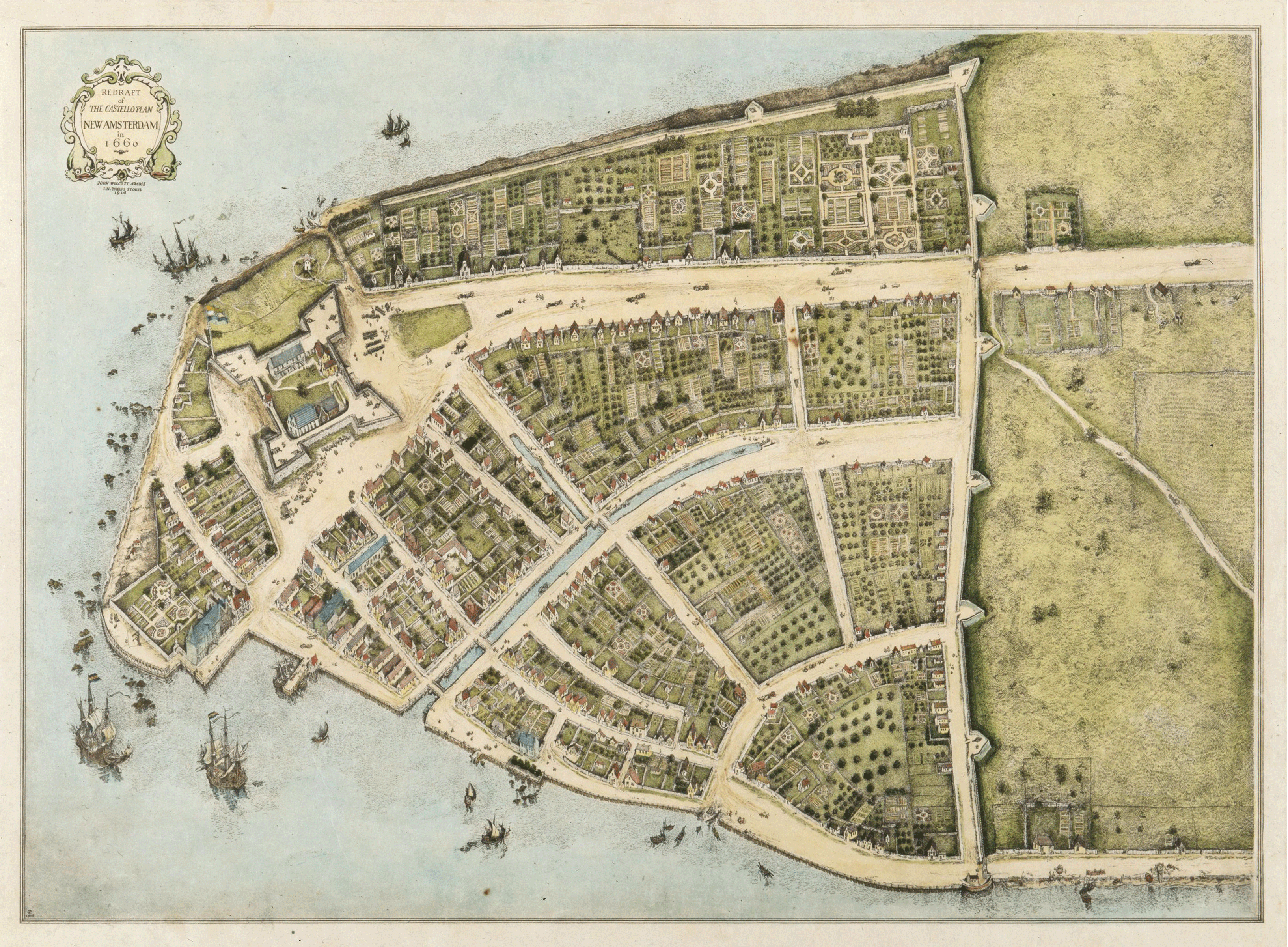
Illustrazione di Manhattan nel 1660.
Fonte: Wikimedia Commons
Fin dalla nascita della colonia, il porto di New York fu il motore economico della città. La sua importanza crebbe anno dopo anno e il piccolo villaggio iniziò a espandersi e strutturarsi per accogliere una popolazione in crescita e offrire le infrastrutture necessarie al fiorente commercio marittimo. Il sistema viario era alla base di questo sviluppo: essenziale per garantire l’efficienza del porto, ma privo di una regolamentazione pubblica. Le strade venivano realizzate da privati, in autonomia, senza alcun coordinamento o controllo collettivo.
Questa situazione favorì un’espansione rapida, ma disordinata, in cui gli interessi individuali spesso prevalevano sul bene comune. Con il tempo, furono introdotte alcune limitazioni, e il Consiglio Comunale cominciò ad assumere un ruolo più attivo nella gestione urbana, fino ad arrivare, nel 1803, a vietare esplicitamente la costruzione di strade dettata da soli interessi privati.
Dopo la Guerra d’Indipendenza, consumata tra il 1775 e il 1783, la popolazione di New York crebbe in maniera vertiginosa. Alla fine del XVIII secolo, la città contava più di 30.000 abitanti, a cui si sommavano altri 20.000 circa delle campagne circostanti, che sarebbero ben presto divenute parte della città stessa. Era il momento di un piano urbanistico capace di governare la rapida espansione della città.
Nel 1796, Casimir Goerck fu assunto dal Consiglio della città per dividere le terre di proprietà del Comune in lotti da vendere o affittare. Il risultato fu quella che passò alla storia come “Map of the Common Lands”: il territorio era diviso in lotti rettangolari di dimensioni simili, distribuiti su tre grandi viali che percorrevano l’isola longitudinalmente. Il piano non fu mai realizzato, ma i tre viali disegnati da Goerck corrispondono proprio alle odierne 4th, 5th e 6th Avenue.
Nel 1803, Goerck fu richiamato dal Consiglio, assieme al collega Joseph François Mangin, per realizzare la prima mappa ufficiale della città dopo la Rivoluzione. La proposta fu una riorganizzazione del sistema viario della zona urbanizzata dell’isola e uno sviluppo del nord secondo un mosaico di aree organizzate a griglia ortogonale, ruotate tra loro secondo angoli variabili. Il progetto non piacque al consiglio, che ne ordinò la distruzione, ma anche il seme della griglia era piantato.
La profezia urbanistica. Nel 1807, il Consiglio incaricò tre commissari — Gouverneur Morris, Simeon De Witt e John Rutherfurd — di elaborare un piano per l’espansione della città, da completare entro il 1811. Nello stesso atto di nomina, si specificava che il progetto avrebbe dovuto riguardare l’intera isola, ad eccezione delle aree già urbanizzate di Lower Manhattan, Greenwich Village e West Village. Per limitare disagi e resistenze da parte dei proprietari terrieri, venne inoltre previsto un meccanismo di gestione degli espropri, basato sulla valutazione del danno e del beneficio derivanti dall’attuazione del piano per ciascuna proprietà coinvolta.
Subito dopo la nomina, i tre commissari assunsero John Randel Jr. come ispettore generale, figura che si rivelò cruciale per lo sviluppo e la realizzazione del piano. Insieme alla sua squadra, Randel si occupò innanzitutto del rilievo dettagliato dell’intera isola, scontrandosi con l’ostilità dei proprietari terrieri che consideravano l’indagine come un preludio all’esproprio delle loro proprietà. In seguito a vari episodi di sabotaggio, alcuni dei quali portarono Randel persino all’arresto per violazione di domicilio, lo Stato approvò una legge che autorizzava formalmente gli ispettori a entrare nelle proprietà private e ad abbattere gli alberi che ostacolavano il completamento dei rilievi.
Nel 1811 i commissari presentarono il piano, passato alla storia come Commissioners’ Plan:
la Griglia di Manhattan.
Furono realizzate per il Consiglio, come da richiesta, tre mappe manoscritte che illustravano il piano del 1811.
Una di queste è stata resa fruibile e consultabile in maniera interattiva nel sito realizzato dal Museo della Città di New York dedicato alla grande griglia. Per usufruirne, è sufficiente cliccare nel titolo di questa box.
“Si tratta del più coraggioso atto profetico della civiltà occidentale: la terra che spartisce è vuota; la popolazione che descrive, ipotetica; gli edifici che individua, fantasmi; le attività che concepisce, inesistenti”
- Rem Koolhaas
Estratto dal libro "Delirious New York", pag. 16
Il piano prevedeva l’organizzazione dell’isola secondo un reticolo di strade ortogonali tra loro: 155 streets larghe 60 piedi e 12 avenue larghe 100 piedi. La griglia generava lotti quasi identici, lunghi 200 piedi in direzione nord-sud e di larghezza variabile, che diminuiva dal centro dell’isola verso le coste.
L’isola era concepita come una tabula rasa, senza tener conto né della topografia del territorio né delle preesistenze, salvo qualche rara eccezione.
Le origini dell’impianto a griglia vanno ricercate nelle tradizioni urbanistiche europee: i coloni spagnoli giunti nel Nuovo Mondo svilupparono le nuove città secondo la cosiddetta Legge delle Indie, un sistema di organizzazione ortogonale di strade e lotti, riconoscibile in molte città del Sud America e non solo. Nel Nord America, tra gli esempi più significativi si possono citare Philadelphia e Washington.
La griglia di Manhattan, tuttavia, è diversa: i lotti sono più piccoli rispetto a quelli delle altre città, condizionando così le tipologie edilizie che li avrebbero occupati. Inoltre, mentre nelle altre griglie urbane si trovano spesso piazze o edifici di rappresentanza a interrompere la regolarità del tessuto, nel piano di Manhattan si predilige una rigorosa standardizzazione.
“Uno dei primi oggetti che attirò la loro attenzione fu la forma e il modo in cui l’opera avrebbe dovuto essere condotta; vale a dire, se limitarsi a strade rettilinee e rettangolari, oppure se adottare alcuni di quei miglioramenti suppositi come cerchi, ovali e stelle, che certamente abbelliscono un piano, ma la cui utilità e comodità possono essere messe in discussione. Nel considerare tale questione, non si poteva non tenere a mente che una città è composta principalmente da abitazioni umane, e che case con lati diritti e angoli retti sono le più economiche da costruire e le più comode in cui vivere. L’effetto di queste riflessioni semplici e chiare fu decisivo.”
Traduzione di un estratto della trascrizione del Remarks of the Commissioners, March 22, 1811
È un piano razionale, cinico, spietato, ma al tempo stesso profondamente democratico e visionario. Quasi un’utopia, se non fosse che è stata realizzata.


Pianta della città di Lima, realizzata secondo le Leggi delle Indie, il corpo normativo emanato dalla corona spagnola per regolamentare la vita politica, sociale ed economica nei territori coloniali delle Americhe e delle Filippine.
Fonte: Wikimedia Commons
Pianta della città di Washington, marzo 1792, incisione su carta. Fonte: Wikimedia Commons
La realizzazione di un’utopia. L’audace Commissioners’ Plan, concepito su un piatto foglio di carta, andava ora trasferito sulla complessa geografia dell’isola. Manhattan era infatti un ecosistema eterogeneo, che includeva, all’estremo sud, il nucleo urbanizzato, e proseguendo verso nord, un mosaico di fattorie, campi, colline, affioramenti rocciosi, stagni, paludi e spiagge.
Il lavoro di Randel fu fondamentale anche in questa fase: innanzitutto completò il rilievo iniziato anni prima, posizionando marcatori di rilevamento in ogni futuro incrocio della griglia per guidare la realizzazione effettiva del sistema viario. I primi marcatori, di dimensioni ridotte e realizzati in legno, venivano spesso rimossi dai proprietari terrieri che volevano ostacolare il lavoro, costringendo Randel e la sua squadra a ripetere il rilievo delle zone interessate. Per porre rimedio, lo Stato di New York promulgò una legge che stabiliva che i marcatori dovessero essere di marmo bianco, alti tre piedi: la dimensione avrebbe reso impossibile la rimozione, mentre il materiale pregiato attestava il coinvolgimento dello Stato nella procedura. Randel misurò a piedi oltre 1.600 km di territorio in dieci anni e, tra il 1811 e il 1818, piantò 1.549 marcatori in marmo e 98 chiodi di ferro, utilizzati nei punti in cui la dura roccia affiorante impediva l’uso del marmo.
Nel 1820 Randel completò l’elaborazione di un atlante di 92 tavole, in cui minuziosamente sovrapponeva lo stato di fatto dell’isola, con tutte le indicazioni topografiche, al progetto della griglia. Nello sito sull'argomento realizzato dal Museo della Città di New York, è possibile consultare la mappa composita interattiva che mette insieme le 92 tavole.
Inventata nel 1620 da Edmund Gunter, la catena di Gunter è uno strumento utilizzato per la misurazione delle distanze. Si tratta di una catena metallica lunga 66 piedi (circa 20,12 metri), composta da 100 maglie identiche, ciascuna lunga 0,66 piedi (circa 20 cm). Per effettuare la misurazione, due assistenti ne tenevano le estremità e, una volta posizionata a terra lungo la linea da rilevare, piantavano un picchetto alla fine per segnare la distanza e poi spostavano la catena in avanti fino al punto finale. Contando il numero di catene si otteneva la distanza complessiva. Per garantire che il percorso fosse rettilineo e in piano, si ricorreva anche ad altri strumenti come la livella, la squadra e il teodolite.
Il teodolite è uno strumento di precisione utilizzato per misurare angoli orizzontali e verticali, ancora oggi impiegato nella sua versione digitale. Si tratta di un telescopio montato su un asse verticale, per misurare angoli verticali, e su una base girevole a 360°, per misurare angoli orizzontali. I cerchi graduati permettono di leggere i gradi, mentre le livelle a bolla garantiscono la posizione orizzontale dello strumento. Per effettuare la misurazione, l’apparecchio viene montato su un treppiede e regolato con attenzione: una volta definito il piano di riferimento (piano zero), il telescopio viene orientato verso il punto da misurare, e si legge il valore sull’arco graduato.
Completati definitivamente il rilievo e la posa dei marcatori, si poté avviare l’apertura delle strade, articolata in due fasi principali. La prima consisteva nell’esproprio dei terreni privati, accompagnato da una valutazione del danno o del beneficio arrecato dalla nuova viabilità, con il conseguente riconoscimento di un indennizzo. Solo successivamente si procedeva alla realizzazione effettiva delle strade: il terreno veniva livellato, regolarizzato e infine pavimentato. Il piano del 1811 stabiliva il tracciato delle strade, ma non ne specificava le pendenze, poiché non teneva conto dell’orografia dell’isola. Ciò rese particolarmente complessa e onerosa l’attuazione del progetto in alcune aree, dove fu necessario intervenire pesantemente sul territorio per adattarlo alla griglia.
La realizzazione della griglia cancellò dal territorio quei riferimenti topografici che fino ad allora avevano guidato l’orientamento e l’organizzazione dello spazio. I lotti di terra divennero tutti uguali, standardizzati e, per questo, acquisirono lo stesso valore e le medesime potenzialità.
Complice anche l’inarrestabile crescita demografica, il mercato immobiliare newyorkese iniziò una rapida ascesa. A questa stagione appartengono imprenditori del calibro di John Jacob Astoria, committente di alcuni degli edifici più iconici di Manhattan, tra cui il Waldorf, demolito per fare spazio all’Empire State Building, e il celebre Waldorf-Astoria, ancora oggi esistente.

Mechanics’ Magazine and Register of Inventions and Improvements, Giugno 1833.
Fonte: The Greatest Grid
Negli anni ’30 dell’Ottocento, una pratica si fece sempre più comune tra quei proprietari che si ritrovavano ad avere proprietà nel bel mezzo di una futura strada della griglia: il trasferimento dell’intera casa. L’inventore di questo sistema fu il figlio di un traslocatore, Simeon Brown, che nel 1933 pubblicò il suo trattato “Metodo per spostare edifici in mattoni”: le case venivano trasportate utilizzando una struttura simile a quella che veniva usata per spostare le barche. Brown stimava di poter spostare le case di un metro al giorno, e di aver traslocato in tutto 900 edifici.
Central Park. Nelle Osservazioni al piano che accompagnavano il disegno del 1811, i commissari dichiaravano di non aver previsto la realizzazione di grandi spazi verdi, ritenendoli superflui, poiché “quei grandi bracci di mare che abbracciano l’isola di Manhattan rendono la sua posizione, in termini di salute e piacere, come anche di comodità del commercio, particolarmente felice”. Tuttavia, tra il 1821 ed il 1855, New York quasi quadruplicò la sua popolazione e i newyorkesi iniziarono a lamentare la necessità di uno spazio dove poter sfuggire dalla rumorosa e caotica vita urbana.
Nel 1853 la città acquistò un'area di 700 acri (2,8 km²) al centro di Manhattan per la realizzazione di un parco pubblico. Pochi anni dopo fu indetto un concorso di progettazione: il progetto vincitore fu quello di Frederick Law Olmsted e Calvert Vaux, che prevedeva un unico grande parco in grado di occupare l’intero lotto, uno “svuotamento” della griglia dalla Fifth alla Eight Avenue, dalla 59th alla 106th street (il parco fu esteso fino alla 110th nel 1863).
Pur proponendosi come un’evasione dalla rigidità della griglia, i confini netti e rettilinei e gli ingressi perfettamente allineati con le strade circostanti rivelano in realtà un profondo rispetto per la regolarità formale dell’impianto urbano.
Il progetto, concepito come un paesaggio naturalistico idilliaco, includeva la costruzione di 40 ponti, tutti diversi tra loro. L’organizzazione delle varie circolazioni fu l’aspetto più innovativo del progetto: i percorsi di pendoni, cavalli e altri veicoli erano separati tra loro, e le vie dedicate al traffico erano ribassate, così da non interrompere l’unità scenografica del paesaggio.

Central Park, progetto del 1875.
Fonte: Wikimedia Commons
Le dimensioni di Central Park apparivano all’epoca ingiustificate: quando ne cominciò la costruzione, la popolazione dell’isola era ancora concentrata a sud dell’area designata, mentre nella parte settentrionale doveva ancora essere realizzato persino il sistema viario. Tuttavia, Frederick Law Olmsted difese con decisione la sua scelta, certo che la griglia urbana si sarebbe presto estesa e che il parco avrebbe contribuito ad aumentare il valore degli immobili circostanti.
Central Park, come la griglia, fu un atto profetico.
Il parco fu completato nel 1876, quando la trasformazione dell’Upper East Side prevista da Olmsted, era già in atto. Alla fine dell’Ottocento, infatti, la Fifth Avenue era ormai conosciuta come la “Millionaires' Row”, la strada dei milionari, per via delle famiglie più ricche e influenti della città che vi avevano stabilito la loro residenza. Nello stesso periodo, un’altra area dell’Upper East Side iniziò la sua trasformazione: nel 1876, il tratto di ferrovia dalla 59th alla 96th street dell’attuale Park Avenue venne interrato; la via venne ampliata e arricchita con un parterre centrale alberato, che portò al nome che oggi conosciamo. In breve tempo, divenne una delle strade più ambite della città.
A causa della sua conformazione geologica più complessa, l’area dell’Upper West Side si sviluppò più lentamente. Fu il magnate Edward Clark, erede della Singer, a dare il via alla trasformazione del quartiere con importanti investimenti immobiliari, tra cui il celebre Dakota Building, affacciato su Central Park. Alla sua inaugurazione, nel 1884, in pochi credevano nel successo dell’iniziativa, ma furono rapidamente smentiti: l’edificio divenne uno degli indirizzi più prestigiosi della città.

La Millionaires' Row, nella Fifth Avenue, dopo una nevicata nel 1905. Fonte: Wikimedia Commons

The Dakota, 1890. Fonte: Wikimedia Commons
Eccezioni alla regola. Se Central Park non può considerarsi una vera eccezione alle regole della griglia, esistono invece diversi casi che rientrano a pieno titolo in questa categoria, dal singolo edificio alla strada, fino all’intero quartiere.
Uno degli esempi più evidenti è la Grand Central Terminal, forse l’edificio che più esplicitamente interrompe la regolarità della griglia, collocandosi al centro di Park Avenue. La ragione di tale “trasgressione” è legata allo sviluppo della rete ferroviaria cittadina: all’epoca della costruzione dell’attuale stazione, all’inizio del Novecento, il trasporto ferroviario era ancora essenziale per la vita economica della città e questo fece prevalere la funzionalità dello scalo sulla coerenza geometrica della griglia.
Un altro caso emblematico è Broadway, celebre per il suo tracciato obliquo rispetto alla maglia ortogonale. Non inclusa nel Commissioners’ Plan del 1811, Broadway risale al periodo coloniale ed era l’asse principale del primo insediamento urbano. Nonostante la nuova pianificazione, la strada continuò a essere utilizzata e venne progressivamente ripristinata tratto dopo tratto. Nel tempo, ricevette anche un trattamento urbanistico speciale: fu allargata e arricchita secondo il modello delle passeggiate europee, acquisendo un carattere distinto rispetto alle altre strade della griglia. Il suo tracciato irregolare crea episodi urbanistici particolari, come i cosiddetti “papillon”: spazi triangolari generati dall’incrocio tra Broadway e le sette avenue della griglia che attraversa. Questi slarghi sono diventati luoghi spontanei di socialità urbana, vere e proprie pseudo-piazze. Il più famoso tra questi è oggi noto come Times Square.
Un’altra significativa eccezione alla regola è rappresentata dal fenomeno del superblocco: l’unione di più lotti della maglia per realizzare complessi residenziali, commerciali o direzionali. Nel XX secolo, l’affermazione del modello della torre circondata dal verde, ispirato agli ideali modernisti, alimentò questo tipo di sviluppo. Un esempio evidente si può osservare sulla riva est di Lower Manhattan, dove la regolare trama della griglia cede il passo a isolati molto più ampi, occupati da edifici alti immersi nel verde.
Ma forse la più significativa deviazione dalla griglia si ebbe durante la pianificazione e la successiva urbanizzazione del West Side e dell’area a nord di Central Park. A partire dagli anni ’60 dell’Ottocento, anche grazie al successo del nuovo grande parco, si diffuse tra i cittadini una certa nostalgia per il paesaggio bucolico che aveva un tempo caratterizzato l’isola, e che sopravviveva solo nei settori ancora non edificati a ovest e a nord del parco. Questo sentimento, unito alle oggettive difficoltà tecniche legate alla presenza di colline ripide e affioramenti rocciosi, spinse gli sviluppatori a chiedere una revisione del piano originario.
Nel 1867, il Consiglio dei Commissari di Central Park si fece promotore della ripianificazione delle aree ancora non urbanizzate. A guidare il progetto fu Andrew Haswell Green, fiero critico del piano del 1811, che accusava di ignorare completamente la conformazione naturale del territorio.
Il nuovo piano per il West Side mantenne dove possibile la griglia, ponendosi in continuità con il piano originale, ma ne cancellò alcune porzioni in corrispondenza delle aree più impervie, dove fu invece prevista la realizzazione di parchi. Nella zona a nord di Central Park, invece, Green adottò un approccio più morbido e organico: dopo uno studio approfondito del clima e della morfologia del territorio, propose un impianto meno rigido, ispirato dalla bellezza naturale dell’area: abbandonò quasi del tutto il sistema a griglia, prediligendo grandi viali progettati in modo da seguire l’andamento del terreno, e creò un grande parco curvilineo lungo tutta la costa ovest del quartiere.



Vista verso ovest da Corlears Hook in direzione del Manhattan Civic Center. La foto mostra uno dei superblocchi che caratterizza la riva est di Lowe Manhattan. Fonte: Wikimedia Commons
La nuova Grand Terminal Station in costruzione.
Fonte: Wikimedia Commons
Longacre Square nel 1919. Prese l'attuale nome di Times Square nel 1904 dopo che il New York Times vi trasferì la sua sede. Fonte: Wikimedia Commons
La terza dimensione. Nel 1853, Manhattan ospitò l’Esposizione Internazionale dell’Industria, due anni dopo il grande successo della celeberrima Esposizione del 1851 di Londra. L’obiettivo era mostrare le più recenti invenzioni industriali americane e affermare il ruolo degli Stati Uniti come giovane ma determinata potenza globale. L’evento non ebbe un grande successo di pubblico, ma segnò simbolicamente l’inizio della trasformazione di Manhattan.
Per l’occasione furono costruiti un padiglione in ferro e vetro, sul modello del Crystal Palace, e una torre panoramica in legno alta 315 piedi (circa 96 metri), il Latting Observatory: un primo, audace prototipo di grattacielo.
All’interno del padiglione espositivo, una dimostrazione attirò più delle altre l’attenzione: Elisha Otis, salito su una piattaforma sospesa, tagliò teatralmente la fune di sollevamento per dimostrare l’efficacia del suo innovativo freno di sicurezza per ascensori. Tre anni dopo, Otis installò il primo ascensore per passeggeri in un grande magazzino di New York, aprendo la strada alla città verticale.

The Latting Observatory.
Fonte: Wikimedia Commons

Dimostrazione di Elisha Otis del suo meccanismo di prevenzione della caduta libera, Crystal Palace, 1854. Fonte: Wikimedia Commons
Nel 1890, con la costruzione del New York World Building, alto 106 metri, il grattacielo divenne una realtà. Da quel momento, l’evoluzione dello skyline di Manhattan non si sarebbe più fermata. I nuovi edifici, svettando dai lotti regolari e definendone i confini, formano veri e propri “muri stradali” che esaltano l’ordine della griglia e, insieme, spingono lo sguardo verso il punto di fuga centrale, verso l’infinito. Nessun edificio prevale, la griglia è l’unica protagonista.
Dopo aver raggiunto la sua compiutezza sul piano, la griglia ha continuato la sua evoluzione nello spazio, trovando nella terza dimensione la sua forma di monumentalità.

Lo skyline di Manhattan nel 1908.
Fonte: Wikimedia Commons
Tre consigli per proseguire il viaggio:
Il sito, curato dal Museo della Città di New York, raccoglie tutte le informazioni e fonti sulla genesi della griglia di Manhattan, comprese le mappe interattive ad alta definizione del piano del 1811 e del rilievo del 1820.
di Rem Koolhaas
Pubblicato per la prima volta nel 1978 e riedito più volte, è una riflessione critica e creativa sull'evoluzione urbana e architettonica di Manhattan, considerata da Koolhaas un laboratorio di sperimentazione del modernismo e della cultura metropolitana.
Non c'è posto migliore di Midtown per sperimentare la griglia nella sua forma più compiuta: è il luogo dei muri stradali e dei grattacieli, il luogo dove la griglia conquista lo spazio e diventa tridimensionale.
Per non perderti le ultime uscite e tutti gli aggiornamenti!